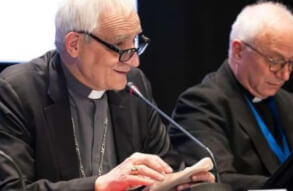Mons. Baronio: Niente potrà essere più come prima
Pubblichiamo postuma una riflessione di mons. Luciano Baronio, già responsabile del Centro Studi della Caritas Italiana, Segretario della Commissione Giustizia della CEI, docente di teologia pastorale alla Pontificia Università Lateranense e assistente spirituale alla Università Cattolica

“Compositio loci”
Se si dice pandemia si dice globalità a motivo della estensione che copre tutto il pianeta, contemporaneamente – caso unico nella storia – che non risparmia nessuno, né persone né territori. E tocca ogni aspetto e ambito di vita individuale e sociale, con crisi, lutti e limitazioni di ogni genere. E’ devastante! non risparmia nessun ambito: dal sanitario, alla ricerca scientifica, al problema ecologico, a quello antropologico, ai rapporti interpersonali e sociali, all’aspetto economico e politico, e non ultimo a quello spirituale.
Stando così le cose, siamo legittimati, anzi spinti, a fare considerazioni ampie, - a “prendere il largo” – per riflessioni globali che puntano a darne non solo una descrizione con il racconto di ciò che è avvenuto, ma a darne una spiegazione che metta pace nella mente e nella vita. Non dicendo perciò cose scontate, ma audaci che possono sembrare, a prima vista, irrealizzabili perché sembrano rasentare l’utopia. Tenendo conto, in generale, che è meglio morire di utopia che di noia. Dunque, siamo chiamati a pensare in grande anche le azioni quotidiane per dare senso compiuto a questa drammatica vicenda e raccogliendone anche i frammenti perché nulla vada perduto. E aprendoci al futuro. Sperando che presto, percorsa la terra, il virus precipiti nell’abisso e si spenga definitivamente.
La stagione difficile tuttora ben presente, per le perdite e i danni gravissimi procurati. Solo una grande riflessione, può aiutarci a pensarla e a viverla con senso di responsabilità, cogliendone gli insegnamenti per una risposta di solidarietà che riguarda tutti: singoli, famiglie, istituzioni e comunità. La coronavirus giunge come ultima, in ordine di tempo, tra le molte che si sono susseguite in modo impressionante, soprattutto in questi ultimi anni, anche a livello internazionale, che di volta in volta ci hanno rattristato e colpito profondamente. Il pianeta è irrequieto, la natura soffre, manomessa in molti modi, ora manifesta il suo malessere e, in certo modo, restituisce i danni subiti, con gli interessi! Per cui siamo tuttora in stato di emergenza da affrontare insieme, unendo tutte le forze, e con il coraggio e l’intelligenza necessari. La riflessione che segue vuole aiutare, alla comprensione dello stato di emergenza e alla risposta più adeguata possibile da parte dello Stato, della società nel suo insieme e con particolare attenzione a ciò che è richiesto alle comunità cristiane, chiamate, per vocazione, a precedere.
Il discorso, perciò, si allarga anche allo scopo di lasciare traccia dei nostri pensieri a chi seguirà e indicazioni per il loro futuro.
Ne nasce quasi una antologia di temi, spunti, riflessioni e proposte che costituiscono uno “strumento di lavoro” aperto a ulteriori contributi, per un progetto che dia fisionomia e unità all’impegno comune.
Definizione di emergenza: sue caratteristiche
Il fattore "emergenza"
Anzitutto, per chiarezza, va definito il fattore “emergenza” per le caratteriste che presenta.
È una costante
Pur costituendo una eccezione nei confronti della vita ordinaria, è un fattore che fa parte della esistenza individuale e sociale. E’ infatti una costante della storia dell'umanità, con la quale ogni generazione ha dovuto fare i conti. Tanto che molto si può imparare dal confronto con altre emergenze o epidemie del passato, sia dal punto di vista sanitario che sociale, e soprattutto per la risposta coraggiosa messa in atto con il coinvolgimento popolare, suscitato e guidato da personaggi autorevoli e, a volte, carismatici, alcuni dei quali hanno dato vita a istituzioni importanti giunte fino a noi. L’emergenza è da mettere in preventivo, soprattutto per una società come la nostra, per la quale alle calamità naturali, sempre possibili, va aggiunto il rischio di disastri provocati dall’uomo. Rischio assai accresciuto - anche a motivo delle tecnologie "avanzate", come hanno ampiamente dimostrato i “fatti recenti”.
Quali caratteristiche? L’emergenza si presenta con caratteristiche che la definiscono in un modo inequivocabile. Anzitutto é un fatto eccezionale, anche se negli ultimi anni - a causa di molteplici fattori e di una informazione più tempestiva e più completa - ne sembra aumentata la frequenza. Si pensi, ad esempio, alle guerre cosiddette "locali o regionali" o al fenomeno della siccità, delle frequenti alluvioni, dovute al cambiamento climatico, dei terremoti, della fame causata dalla penuria di cibo e di acqua… o al lungo elenco di avvenimenti calamitosi sul piano interno ed internazionale sui quali è attirata quotidianamente l’attenzione dell'opinione pubblica. Come "fatto eccezionale" richiede, di sua natura, una risposta altrettanto eccezionale, sia per la rapidità dell’intervento, sia per il coinvolgimento delle forze sociali. È un fatto complesso difficilmente governabile, perché tende a sconvolgere la vita, che è messa in crisi nelle sue dimensioni vitali. Come è avvenuto. È un fatto improvviso. Anche quando è prevedibile o addirittura preannunciato. Chi ne è colpito lo è sempre di sorpresa. Essa, per richiamarci ad un’immagine evangelica, piomba addosso proprio "come un ladro" (Luca 12, 39). Il fatto che l’emergenza sia improvvisa la rende ancora più traumatica perché fa passare, talora in pochi secondi, dalla vita tranquilla alla tragedia. È un fatto doloroso che produce sofferenze, spesso indicibili, aumentando così le "disuguaglianze" all’interno della stessa società e tra comunità e popoli diversi. È un evento che chiama in causa la responsabilità dell’uomo per i disastri di varia natura provocati direttamente o indirettamente dall’uomo. La responsabilità dell’uomo è chiamata in causa soprattutto per gli eventi calamitosi chiaramente riconducibili alle sue scelte morali. Si pensi, ad esempio, alle guerre, alle persecuzioni politiche, alla violazione sistematica dei diritti umani, ma anche alle carestie, alla siccità, alla fame, come pure agli accadimenti alla cui origine ci stanno l'imprevidenza umana, l'omissione di atti dovuti. Il cattivo rapporto con la natura o la logica del profitto ad ogni costo non guarda ai danni procurati alle persone, alla collettività o all'ambiente naturale. Per questo non basta una risposta puramente tecnica; pur necessaria perché richiede una risposta etica
Una risposta a più voci
Apertura ecumenica
La solidarietà è una parola ed una realtà che tutti possono capire. E’ un valore unificante "ecumenico", come ci ricorda Papa Francesco. Se essa è apprezzabile nella vita ordinaria, Io è, maggiormente, nei momenti di emergenza. quando è chiamata a trovare, ogni volta, strade e metodi proporzionati alla gravità dei problemi. Nella consapevolezza che nessuna persona o realtà sociale può affrontare da sola un’emergenza grave come quella provata. L'unica solidarietà adeguata è quella a più voci, costituita dall’apporto di tutte le componenti il corpo sociale, coordinate da chi ne ha il compito e la responsabilità, cioè dallo Stato, come insegna la nostra Costituzione che ha nella solidarietà sociale e un principio cardine. Dimensione ecumenica: La gravità dell’epidemia e l’urgenza di intervenire spinge ad accettare la collaborazione di tutte le forze disponibili. Apprezzando ogni opera compiuta da qualsiasi, anche da chi non condivide la stessa visione della vita e della politica o gli stessi valori ispirati alla fede. L’esperienza insegna che lo Spirito suscita risposte sorprendenti in persone che nessuno pensava capaci di gesti di altruismo, tanto importanti e talvolta eroici, A livello istituzionale, cui vanno aggiunte le varie manifestazioni di collaborazione spontanea. A questo proposito ci soccorre S. Tommaso d’Aquino il quale ha scritto – nel libro “Super Job“ a commento del Libro di Giobbe – che la “ Veritas”, la verità da qualsiasi persona venga detta e il “bonum” il bene da chiunque compiuto vengono dallo Spirito santo (Tommaso Super Job, I, lect.3, n° 103). Peraltro ne sono un sintomo e una spia anche i frequenti riferimenti a luoghi, avvenimenti e personaggi, che costellano il linguaggio quotidiano con locuzioni che hanno un’origine ed un sapore biblico o ecclesiastico. Alcune proverbiali, sorprendenti in una società secolarizzata.
Emergenza e vita quotidiana
La solidarietà "da emergenza" non è di natura diversa da quella che dovrebbe ispirare i rapporti quotidiani. Se non si crea un costume di solidarietà nella vita quotidiana, anche una risposta generosa nell’emergenza, difficilmente sarà una risposta di amore autentico. Chi non è abituato a condividere nella normalità le sofferenze dei vicini, è quasi impossibile che riesca a farlo, nei riguardi dei lontani che non conosce e che, tutto sommato, gli sono estranei, anche quando ne sentisse compassione. Di qui l'importanza fondamentale della educazione permanente alla solidarietà che punta a creare un rapporto stabile da far crescere in ogni ambiente, quali, ad esempio: sul lavoro, nella vita economica, sindacale e politica ecc., ma soprattutto in quelli che hanno una funzione educativa quali la famiglia, la scuola, e il volontariato – che il Presidente Mattarella, ha qualificato come “corpo intermedio”! della Repubblica - e poi la comunità cristiana. La scuola, in aggiunta, offre condizioni oggettivamente favorevoli, dal punto di vista pedagogico, per la libertà didattica che la caratterizza, che oggi può avvantaggiarsi anche di sussidi audiovisivi particolarmente efficaci. e di Internet che permette di continuare la sua attività anche quando sono sospese, per forza maggiore, le lezioni in aula. Evitando ritardi nello svolgimento dei programmi e dannose interruzioni del percorso accademico degli studenti. L’impegno della scuola, ad ogni livello, è finalizzato, a fronte della caduta del senso civico, a preparare i giovani a vivere una “cittadinanza attiva” che è la forma più alta di solidarietà.
Il coraggio necessario
Per poter affrontare adeguatamente l'emergenza va guardata in faccia con coraggio, studiandola o almeno conoscendola nelle sue componenti, nelle sue dinamiche e nelle sue conseguenze onde, all’occorrenza, poterle fronteggiare. Imparando da chi ha fatto analoghe esperienze prima di noi, in Italia o altrove. Più la si conosce più la si può controllare anche prevenendola, per quanto possibile, evitando sbagli, e educando all’auto-protezione, singoli e comunità.
Una visione ampia
La solidarietà in un contesto di l’"emergenza”, punta a delle mete: 1 - Tende al coinvolgimento di tutto il corpo sociale, aprendosi a tutte le collaborazioni e a tutti gli apporti. Anzi ne va in cerca e li suscita mediante con vasta sensibilizzazione attraverso un’informazione precisa e continuata. È una solidarietà che accetta di imparare. L’emergenza può costituire per tutti una lezione di vita. Infatti; ridimensiona i problemi, a volte fittizi, della vita quotidiana e mette in evidenza aspetti dimenticati. Si esprime in modo diversificato, distinguendo tempi e modi. All'inizio interviene con un’azione immediata che ha il carattere dell’urgenza, in seguito con prestazioni che tendono a riportare la vita alla normalità: soprattutto punta ad un modo diverso di pensare e di vivere., rimettendo a posto la scala dei valori secondo un criterio di essenzialità e importanza; porta in casa domande importanti sul valore della vita, e la sua precarietà‘ e sulla relatività di tante cose considerate "indispensabili"; suscita un autentico sentimento di vergogna di fronte a se stessi, alle lamentele e insoddisfazioni ingiustificate; si interroga sulla solidità delle società, progredite, avanzate, ricche, superbe, e nello stesso tempo fragili, più di quanto si potesse pensare, fino a metterle in crisi. Il pensiero, per analogia, corre alla statua vista in sogno dal profeta Daniele (vedi Daniele 2,31 - 36), imponente, da impressionare, ma che aveva i piedi di argilla. Che si frantumò, rovinando, a causa di un piccolo sasso che si staccò dal monte e che la colpì ai piedi. Umiliandola fino a terra.
La coscienza del limite
Il libro di Giobbe parla del limite là dove è scritto:” chi ha chiuso tra due porte il mare? (…). quando erompeva gli ho fissato un limite. dicendo:” fin qui giungerai e non oltre e qui si infrangerà l’orgoglio delle tue onde!” ( Giobbe 38, 8. 11). Sentenza divina rivolta, per allegoria, ai singoli e alla società. Ci viene in aiuto un pensatore Niccolo’ Cusano con il “De docta ignorantia – la sua opera più celebre. Che riguarda la situazione dell’uomo. “Docta” perché l’uomo qualcosa sa, qualcosa ha imparato, qualcosa gli è stato insegnato, per cui può accedere anche alla conoscenza del mondo soprannaturale che lo supera ampiamente, ma resta sempre vero che è molto di più quello che non sa. Fa eco, molto da lontano, Giovanni Testori quando scrive:” “Amarla fu, sapendo di non saperla mai!”. Dunque permane questa “’ignoranza” che accompagna la vita dell’uomo. A tutti i livelli, anche a livello scientifico, oltre che umano. Che induce alla umiltà. Virtù rara come abbiamo constatato in questi mesi quando, invece di sentirci dire apertamente “non sappiamo” - ciò che avrebbe messo tutti in pace - si è preferito, da parte di alcuni, “dissimulare” e fingere di sapere. E alla fine è subentrata, come naturale, sfiducia e delusione. “Vi è dunque in noi una “dotta ignoranza” istruita dallo Spirito di Dio, che viene in aiuto alla nostra debolezza” (S. Agostino, Lettera a Proba, 130, 14 – 17) In sintesi: ci sono cose che sappiamo, cose che non sappiamo, cose che vorremmo sapere.
Le grandi domande
Dunque “FIT MAGNA QUAESTIO”. che necessita di una riflessione che metta ordine nei pensieri e dia risposte a interrogativi ineludibili, per i quali è il caso di ribadire: -“ fit magna quaestio!”- perché siamo di fronte a interrogativi difficili, più grandi di noi che nascono anzitutto nella coscienza e di riflesso nella società, che é inquieta. E’ qui che serve una lettura alta, non una lettura qualsiasi. Precisamente, una lettura “teologica”, che non può accontentarsi di spiegazioni facili o di luoghi comuni. E che ha ricadute importanti sui soggetti esposti in prima linea che vengono chiamati in causa. Ne citiamo uno solo, tra gli altri, per la vicinanza quotidiana che ha con la gente che vive sul territorio, nelle comunità e nelle città. Si tratta dei presbiteri, per il ruolo che rivestono in ordine all’aiuto spirituale proprio del loro ministero e per quell’aiuto psicosociale che viene loro richiesto dalle circostanze per il quale sono giustamente ritenuti capaci. Ecco il punto! I presbiteri devono sentire come rivolte a sé le frequenti domande (teologiche) che affiorano spontaneamente nella mente e sulle labbra della gente, riguardanti il senso della vita, la sua precarietà, resa drammatica dagli eventi che colpiscono indiscriminatamente gli esseri umani, facendo vittime anche tra i poveri, già provati e tra i bambini. E sul senso della morte che noi moderni, più di chi ci ha preceduto, non riusciamo ad accettare. Tanto che la nostra società ha pensato bene, per sbrigarsela, di rimuoverla, nonostante che la cronaca di ogni giorno ce la butti in faccia, villanamente, senza riguardi e senza ritegno anche nei modi più violenti. I mass media si incaricano di tenerci, puntualmente aggiornati.
Incursioni nella storia, alla ricerca di senso
Come dare una spiegazione? A quali precedenti riferirci, per un confronto? A questo scopo sono in atto, da parte di molti, “incursioni nella storia”. E giustamente! “In cerca di risposte che i viventi non trovano perché smarriti o incapaci. Difronte a questa constatazione viene da pensare che, a differenza di altre epoche - la terra pare che non produca più giganti!! Ci dobbiamo - ahinoi- accontentare! Non dimentichiamo che l’età contemporanea - va detto - ha un rapporto controverso – e a ragione - con il proprio passato perché le pesa per vari motivi. D’altra parte è necessario leggere il passato per poter pensare un futuro possibile. Per questo tutta la “storia può essere considerata contemporanea” (Benedetto Croce). Perché se non conosciamo il passato non possiamo sapere da dove veniamo, chi siamo e non sappiamo a che punto siamo, e come prendere decisioni adatte? L’antico profeta suggeriva ai capi e al popolo smarrito: “fermatevi nelle strade e guardate, informatevi circa i sentieri del passato, dove sta la strada buona e prendetela, così troverete pace” (Geremia 6,16) La storia è paragonabile ad un cantiere aperto nel quale si può leggere in controluce il presente. Infatti è sfogliando i libri di storia che vengono alla luce personaggi la cui vita e il cui pensiero ci stanno davanti. Si sa che i grandi, anche quelli più antichi, pur lontanissimi, hanno con noi una contemporaneità impressionante! Che si palesa soprattutto negli scritti che ci hanno lasciato. Lo afferma Gianbattista VICO nel suo “Vita nuova” con il suo “Corsi e ricorsi storici” ritornati di attualità a livello mondiale. Anch’io mi sono messo in cammino per avere luce. Ho cercato anzitutto dentro di me, poi mi sono guardato in giro e, infine, mi sono rivolto al passato, agli studi compiuti. E così ho re- incontrato tra gli altri, un autore che mi aveva affascinato, fin dal primo incontro, per la cultura poliedrica e perché ha dovuto affrontare problemi vivi e spinosi. Come noi, oggi. Si tratta di Niccolò Cusano, cardinale, teologo, filosofo e scienziato del XIV secolo, molto noto nel mondo accademico ed ecclesiastico di allora, molto commentato, allora come oggi. Il Novecento infatti ha visto il moltiplicarsi di studi e di convegni su di lui - per le sue prese di posizioni, coraggiose, controcorrente, e per le sue pubblicazioni che hanno veicolato. Chi lo avvicina rimane impressionato per l’originalità che attinge a piene mani dalla tradizione, a lui ben presente, che riesce a rivestire di luce vivissima. Appassionato di teologia e di mistica, assetato di verità, quella totale, poliedrica che lo investe nelle sue ricerche ininterrotte. Ciò spiega come, nonostante l’attenzione crescente degli studiosi che da alcuni anni gli dedicano studi e convegni, appaia, per moliti aspetti, ancora sconosciuto ai più. A noi é assai utile anche per l’attenzione che ha coltivato verso l’ Europa allora in formazione, che si dibatteva tra mille problemi. All’inizio del mondo moderno. E ’impressionante la sintonia, già nei titoli delle sue opere, con i problemi che stiamo vivendo. Studioso di prima grandezza ha affrontato temi di carattere filosofico, teologico, e politico, a fronte delle emergenze non da poco del suo tempo, compreso il travaglio dottrinale in atto tra Oriente e Occidente, cui andava aggiunto il problema, allora come oggi, sempre acuto, - anche se oggi messo in sordina anche a causa della pandemia - del rapporto con l’Islam, all’indomani della sua conquista di Costantinopoli, avvenuta nel 1453, che sarà poi chiamata Istambul! Allora l’impressione fu enorme! In seguito a questo fatto traumatico, prese carta e penna, e scrisse il “De pace fidei” con il quale intese gettare le basi per una convivenza pacifica tra le fedi. Da costruire non attraverso lo scontro armato ma con il confronto. Da notare che considerava la pace non solo come fine, come meta da perseguire con tutte le forze, ma come metodo! Intuizione fondamentale. Inoltre, si impegnò per la riconciliazione tra i cristiani di Oriente e Occidente lavorando ad una risoluzione del conflitto, in atto. Come si vede, Il Cusano non si è sottratto alla “mischia” ma vi è entrato attraversandola coraggiosamente, superando pericoli, contrasti e polemiche. Affrontò argomenti difficili di carattere teologico. Come fa nell’opera il “Dio nascosto” dove afferma che Dio anche quando é silente, nascosto, é ben presente alle vicende umane. Perciò silente sì, ma non assente. Come non lo era stato al lamento del popolo colpito a morte per la siccità nel deserto, e che si chiedeva, smarrito, ” Il Signore è in mezzo a noi sì o no? (Esodo, 17,7) Anche allora il Dio “nascosto nella nube”, non si manifestava apertamente davanti al popolo, ma interveniva e agiva, per così dire, per “interposta persona”, e lo fece attraverso Mosè che per suo ordine, fece scaturire acqua dalla roccia. dicendo ai suoi: “Non abbiate paura. Siate forti e vedrete la salvezza che Il Signore opera, oggi per voi “ (Esodo, 14,13). Le persone che fanno del bene, sono la “longa manus” di Dio. Egli opera a favore dell’uomo mediante l’uomo. Sta scritto infatti “Ha riempito l’uomo dello Spirito di Dio perché egli abbia saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro, per concepire progetti e realizzarli “ ( Esodo, 35,31). “Uomini e donne in cuor loro si sono sentiti mossi a dare il proprio contributo per l’opera che il Signore aveva comandato” (ibid. 35, 29). Anche oggi Dio chiama ogni uomo a collaborare per salvare gli altri. Madre Teresa di Calcutta aveva chiaro fin dall’inizio della sua missione che “E’ attraverso le mie mani che Dio va in soccorso ai poveri. Dio parla attraverso la sua Parola, ma anche attraverso gli avvenimenti che hanno in sé, sempre, qualcosa di misterioso. In Dio però – afferma il Cusano che ci sta accompagnando passo passo - tutto si spiega e tutto si ricompone. perché in lui – tesi singolarissima e quanto mai suggestiva! - vi é la “coincidentia oppositorum” - la “coincidenza degli opposti”: in lui avviene la sintesi e si realizza l’armonia dei contrari! Secondo la quale tutto ciò che all’occhio umano si presenta come contradditorio, in Dio si ritrova riconciliato e complementare. Per lui tutto è connesso! Ciò si verifica, per esempio, nel rapporto tra giustizia e misericordia, tra morte e vita - un ossimoro - che in Dio convivono. E allora che “chi perde la vita la trova!” Se dài, ricevi. "De conjecturis” - Anche oggi Dio suscita “il volere e l’operare” (Filippesi 2,13) ed è presente mediante uomini e donne, impegnati in tutto il mondo a cercare una via di uscita dalla pandemia, dalle emergenze, mettendo a servizio degli altri le capacità, le competenze e la generosità. Ad essi dona luce e forza davvero sorprendenti! Qui trova spiegazione l’esplosione di generosità – in verità mai vista prima, in questa misura e in contemporanea, – tra Stati e popoli, lontani e diversi, che hanno dato vita ad una solidarietà internazionale.
Consultare la Bibbia? Perché?
Perché essa è il “grande codice di civiltà” come è stata ben definita dallo studioso canadese Northrop Frye, la quale offre pagine di storia vissuta dal popolo e descrive i comportamenti dell’uomo, in risposta alle vicende, le più diverse. dall’una e dagli altri ci vengono conoscenze utilissime che non trovi altrove. Come si vede abbondantemente! Offre la risposta agli interrogativi importanti che ci assediano. E allora perché consultare tutti i libri, possibili e immaginabili, ascoltare voci, le più diverse, talvolta stonate, inutili se non dannose, e dimenticare il “Libro dei libri”? che ha ispirato, per secoli, intere civiltà, artisti, letterati! pensatori tra i più grandi della storia, sia italiana che europea. Dunque leggere la storia con la Bibbia e la Bibbia con la storia, intrecciandole. Leggere la storia per meglio capire la Bibbia e leggere la Bibbia per meglio capire la storia
“La verità della S.Scrittura deriva da Dio, tratta di Dio, secondo Dio e per Dio” (Breviloquium. S.Bonaventura. Di particolare importanza é il rapporto tra Bibbia e letteratura. Tra il testo biblico che per il linguaggio incisivo, la ricchezza delle immagini, dei simboli può guarire la comunicazione dalla ripetitività monotona delle parole e delle frasi fatte che ampiamente ci affligge, in particolare nella politica. Da far paura. Il riferimento alla Parola di Dio non è, come potrebbe sembrare a prima vista, ad alcuni o a molti - dato il tema che stiamo trattando e soprattutto ciò che andiamo vivendo - una forzatura o una pretesa. La conoscenza della Bibbia ci istruisce su due fattori sempre in gioco, in contemporanea, l’azione di Dio mossa dall’amore e la cattiveria e ignoranza umana che è insipienza. E’ bene conoscerle ambedue! La Bibbia, libro di Dio, è anche libro dell’uomo che presenta la vicenda umana in tutti i suoi aspetti e avvenimenti, nel bene e nel male, comprese le calamità naturali e quelle provocate dall’uomo. Ciascun cristiano, per quanto poco conosca la "storia sacra", facilmente ne ricorda più di una dell’uno e dell’altro tipo. È il caso, per esempio, della tremenda siccità, che ci fu al tempo del profeta Elia, narrata nel 1° libro dei Re (18, 41-46), delle numerose guerre e deportazioni del popolo delle quali parla soprattutto l’Antico Testamento. Anche Gesù ha fatto riferimento ad avvenimenti analoghi dell’Antico Testamento o a fatti di cronaca a lui contemporanei, come quando ha commentato la notizia - riferitagli da alcuni - della caduta della Torre di Siloe che causò diciotto morti (cfr. Luca, 13, 4-5). Egli inoltre ha invitato a leggere le calamità, piccole o grandi, come un richiamo alla conversione, al cambiar vita e alla vigilanza. Lo ha fatto anche quando ha parlato della fine del mondo i cui segni premonitori sono costituiti da terremoti, carestie, pestilenze, guerre e rivoluzioni. Il Signore però non si è limitato a trarre per i suoi ascoltatori insegnamenti morali che gli avvenimenti tragici (calamità) della storia suggeriscono ma ha invitato a farsi solidali con chi è colpito dalla sventura. Lo ha fatto, per esempio: con la parabola del buon samaritano: "Va' e anche tu fa lo stesso!"; di fronte alla folla affamata, quando ha detto agli apostoli: "non è necessario che se ne vadano, date voi stessi da mangiare"; quando parlando del giudizio universale, ha elencato le diverse forme di povertà, quali la fame, la sete, la malattia, la persecuzione, ecc., che possono colpire singoli e collettività e ha concluso assegnando la vita eterna a coloro che hanno esercitato "le opere di misericordia" e condannando invece chi non se ne è curato. Così la comunità cristiana vive come sue non solo le gioie e le speranze, ma anche "le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono» (Gaudium et spes, 1). Questi non sono che accenni all’ampio tema della solidarietà che la Parola di Dio ci offre.
"Sentinella quanto resta della notte?” (Isaia, 21, 11-12).
E’ un interrogativo che nasce a fronte di una pandemia davvero impietosa, che ha messo tutti a dura prova, soprattutto i più fragili. Dobbiamo riconoscere che ci ha messi a nudo, come società e anche come chiesa. Nel bene e nel male, nella forza e nella fragilità. Per cui si presenta simultaneamente come giorno e come notte! Anzitutto il giorno! La pandemia ha portato alla luce energie impensate. Da sorprendere. Che parevano smarrite. E’ apparso chiaro che sotto la cenere c’è il fuoco, là dove non te l’aspetti. E questo ci fa sentire migliori e più forti. Ma la società si è anche rivelata fragile. Si ha la sensazione che siano franati i muri di sostegno, e i muri di cinta delle città medioevali. Si pensavano sicuri, a prova di assalto, la ricchezza, il denaro, lo sviluppo tecnologico, anche la cultura e la scienza. Anche le istituzioni e lo stesso potere, si è rivelato Impotente. E le chiese locali? Si sono svegliate come di soprassalto, spargendo luce e grazia, riversando sull’umanità i doni che le sono stati affidati, fin dalle origini: grazia, vicinanza, consolazione, balsamo, generosità, amore senza limiti fino al dono di sé. Cristiani senza numero, volti sconosciuti, venuti alla luce e apparsi come angeli accanto, a chi stava affrontando, nella solitudine, la epidemia e la morte. Questo è il giorno della luce. Poi la notte. Perchè nella bella “dormiente”, - come possono essere definite alcune chiese locali - vivono cristiani sguarniti di difese interiori, deboli e smarriti come gli “altri” e più degli altri. Si sono trovati, faccia a faccia, davanti alle paure, alla sofferenza e al rischio della perdita della vita. Privi della “memoria” di sé come cristiani. Eppure appartenenti alle comunità dove hanno ascoltato parole importanti, quali il vangelo, la fede, la grazia, l’amore ai poveri, la giustizia sociale, la condivisione, la testimonianza, la corresponsabilità, la pace, la vita eterna. L’uso e la dimenticanza hanno svuotato queste parole della forza e del significato originario. Da farle sembrare più una proclamazione di intenti o uno slogan che un programma di vita. Tutto questo rimanda al tipo di formazione dato e ricevuto, a cominciare da lontano e cioè al tempo della recezione, dei sacramenti dell’iniziazione cristiana. In proposito va segnalata la concessione facile e generalizzata dei sacramenti ai ragazzi e agli adolescenti, molti dei quali giungono impreparati così che, subito dopo, abbandonano in massa la comunità così da diventare estranei e lontani. E spesso critici. E’ mancato un accesso’ guidato “alle fonti”, in primo luogo alla Sacra Scrittura e alla vita della chiesa. E’ sotto accusa una pastorale che si é affidata più alla trasmissione verbale della fede, che alla testimonianza di chi insegna, in primis dei sacerdoti e dei catechisti, ai quali, spesso impreparati, sono stati affidati. A questa situazione intende mettere rimedio la provvidenziale iniziativa del Santo Padre con il motu proprio “ Antiquum ministerium” che istituisce il ministero del catechista per il quale è prevista una preparazione adeguata ed un conferimento con apposito rito liturgico. ***
E’ da riconoscere che spesso anche negli adulti, più che ai contenuti della fede, prevale l’attenzione ai problemi sociali da affrontare. E’ l’aspetto orizzontale della vita che vince per cui non si è avvertito come pericolo il consumismo, scambiato per benessere, cui si sono spalancate allegramente le porte, senza avvertirne i contraccolpi. Accolto senza alcuna resistenza, ha finito per cambiare la logica della vita. Di conseguenza, con il passare del tempo, questo spirito, ha prodotto guasti, disamorando dalle realtà spirituali, così che si sono moltiplicati nel popolo abbandoni e apostasie maggiori del tempo delle persecuzioni da parte dei regimi atei del secolo scorso. Appare evidente la mancanza di una formazione cristiana adeguata, per ’inadeguatezza di una pastorale senza coraggio e mordente. E che inevitabilmente ha perso seguito. Anche questa è notte! Con la quale dobbiamo fare i conti.
Prendere il largo
Che fare? Occorre uno strappo o, meglio, un colpo d’ala! Il “Duc in altum!” evangelico: “prendi il largo!” (Luca 5,4). Vi è una convergenza di fattori e di pensieri, sorprendente, che obbliga a pensare. e a progettare il futuro su basi nuove e con ampi nuovi orizzonti.: E allora vai là dove l’acqua è alta, e profonda! Anche la pandemia ha obbligato ad uscire dal chiuso e a cercare spazio al largo. per respirare e comprendere la molteplicità di aspetti che ha presentato, cui si deve aggiungere la congerie di interpretazioni che fanno ressa. Che si confrontano e talvolta confliggono, con le conseguenze che direttamente o indirettamente ricadono su tutti.. Come ci è dato di constatare ogni giorno.
La ricostruzione deve puntare ai muri portanti dell’edificio.
Anzitutto la “Renovatio Reipublicae” che richiede un cambiamento radicale, una specie di “palingenesi” che ripensi profondamente la “politica”, riguadagnandone il significato e la dignità secondo la migliore tradizione culturale che abbiamo conosciuto nei tempi migliori, presente nei grandi autori. A proposito, può bastare qualche accenno: E’ la politica
A - La politica est “ Causa principalissima” (cfr. Tommaso d’Aquino)
“ La carità politica” (Pio XI)
*La politica è la forma più esigente della carità “(Paolo VI°)
* “E’ la politica l’attività religiosa più alta dopo quella dell’unione con Dio”: u na responsabilità immensa, un severissimo servizio che si assume” (La Pira).
“ “Prediche agli uomini di governo” Opera interessantisima, attuale di Antonio Vieira, gesuita , portoghese, che mette in evidenza le attese ma anche i pericoli e gli abusi.
Illuminante, in merito anche è ciò che scrive Rosmini: ”Ogni società umana é invisibile e visibile. (…) ciò che annoda la società sono i vincoli invisibili, perché le società umane sono unioni di spiriti, non avvicinamenti di corpi” (Filosofia della politica, libro III, cap
Per cui la nuova socialità è da cercare anzitutto “dentro di noi”. Se l’interiorità è da considerarsi prioritaria, il fondamento per la società deve essere spirituale. Se viene offuscata tutti i punti forza vengono tremendamente indeboliti. La violenza scaturisce dall’assenza di un giusto equilibrio tra esteriorità e interiorità, tra corporeità e razionalità.
Si tratta di ripartire dalle ragioni che arricchiscono la vita e danno sapore alla libertà. Più si sviluppano più ci si sente bene.
Lo Stato è debole là dove dovrebbe essere forte!* perché la società, è trasformata insipientemente in luogo di ’insulto, volgarità, e beghe, e perfino di odio – dimenticando che se odi, a tua volta sarai odiato. Spinti in questo da “predicatori” folli, purtroppo vezzeggiati e spesso adulati dai mass-media e nelle piazze, nei quali, inebriati dal “successo” è andato crescendo il delirio di onnipotenza (a parole). Siamo guidati per lo più da saccenti.
Compito immane, cui mettere mano, per realizzarlo, con il contributo di tutti, dando precedenza a chi sta peggio.
La posta in gioco è davvero complessa! Per misurare la realtà e vivere con intelligenza – ci suggerisce Pascal - non basta l’esprit de geometrie, che tende alla conoscenza razionale, analitica, serve anche l’esprit de finesse che si pone domande che nascono dalla interiorità. ( Blaise Pascal, matematico e filosofo – 1623 - 1662 ).
Che fare? La regola è:”fai quel che devi!” superando la pigrizia mentale e quella fisica che dominano la vita di molti, ai quali si può applicare, con ironia – correggendolo, a dovere - il motto della rivoluzione francese :“ Liberté, Egalitè, Fraternité”. Tre grandi parole, suonate come nuovissime, di origine biblica, rivoluzionarie! Se è permessa una chiosa ironica si può affermare che Fraternitè è stata cambiata in Comodité!”. Per cui la regola è: guai a far fatica, guai al sacrificio. Guai a rinunciare a qualcosa per gli altri. Nessuno è così impegnato come chi non ha nulla da fare! Invece: carriera e successo facili e il più presto possibile! Ignorando gli altri. Non temere di avvicinarsi ai grandi Il confronto con autori e opere che hanno segnato di sé la storia.
L’“Ab imis fundamentis”di Francesco Bacone, filosofo e scienziato inglese (1561 – 1626 ) che nell’opera “Instauratio magna” scrive :” instauratio facienda ab imis fundamentis”. Il rinnovamento va iniziato dalle fondamenta. Rinnovare il modo di vivere, di pensare e il tenore di vita. In questo periodo sono state dette e scritte, in merito, parole impegnative.
“Ab imis… ”Molti se lo augurano, pensando che “niente sarà – o dovrebbe essere - come prima”. Certamente siamo ad una svolta. Definirla “epocale”!: non è una parola sprecata. Uscirà di necessità un mondo diverso, si spera migliore. Se la casa traballa occorre por mano ad un rifacimento globale : “ab imis fundamentis”.. E’ urgente ricostruire! Impresa non facile che esige un progetto, richiede tempo e determinazione non comuni. Utopia? Può darsi. Comunque è meglio l’ utopia che la noia, la malinconia o i rimpianti.
Dovremmo forse ispirarci alla famosa “Magna charta libertatum” ? - pensata e nata nel 1215, come trattato di pace, in un periodo di grande difficoltà e di contrasti, considerata dagli storici come “ il più grande documento costituzionale di tutti i tempi”, il più famoso, che ha dato inizio al tempo delle riforme costituzionali, intese a limitare il potere assoluto del re, e che ha influenzato la storia fino a noi.. Nata, in Occidente, ad opera allora delle monarchie in conflitto tra loro ed oggi, lo dovrebbe essere, ad opera, delle Istituzioni nazionali ed internazionali. Si tratta di aprire un grande cantiere per mettere ordine nella confusione anche istituzionale che si è creata, cammin facendo. Non bastano piccoli aggiustamenti o rimedi che poi rimediano poco. Se ne avverte la necessità , anzi l’urgenza e come! ma la nostra società e chi la rappresenta, anche a livello europeo, ne avranno la capacità e la forza? In ogni caso è meglio tentare, che star fermi.
*Qualcosa dovremmo aver imparato dal male comune che ci ha colpito. Che ci ha fatto prendere coscienza almeno di una cosa fondamentale, e cioé della comune appartenenza alla famiglia umana. O ci si salva assieme o non ci sarà salvezza per nessuno. Le differenze e le distanze, prima messe in grande evidenza, per sentirsi diversi dagli altri, e migliori, sono cancellate. Essere ricchi, essere colti, avere un ruolo sociale importante non salva. Siamo tutti – una “livella” ? – ugualmente a rischio, e contagiabili con tutte le conseguenze.
In una parola ci si sta rendendo conto che é il sistema di vita che va cambiato. A partire dallo stile a livello individuale. Tutti chiamati a superare abitudini e comportamenti, sbagliati. Se così avvenisse l’esperienza della epidemia si trasformerebbe in una opportunità di cambiamento provvidenziale. Uscirà di necessità un mondo nuovo. Sprecare questa “occasione” significherebbe che siamo diventati incorreggibili. Con quale faccia ci presenteremo, dopo mesi di riflessione?
*A questo scopo serve darsi delle priorità.
La reformatio ecclesiae
Come è avvenuto molte volte nella storia. Un nuovo inizio, un’alba nuova promessa dal: ”Ecco faccio nuove tutte le cose”(Apocalisse)
Dio costituisce lo snodo per ogni cosa. Perciò la nostra riflessione sale in alto e conduce, volere o no, al vertice - non ci si può fermare prima! – cioè, fino a Dio. Al quale, a ben vedere, pensano o si rivolgono, credenti e non. “La (creatura senza il Creatore, svanisce” (Gaudium et spes 36).
Si tratta di Interagire con Dio. Abbiamo il dovere di sostenere questo sforzo immane anzitutto con la preghiera come Mosè che sul monte alzava le mani a sostegno del popolo che combatteva - perché non vengano meno il coraggio e la forza necessari.
Che cosa attende da noi il Signore? in particolare alla chiesa, e a noi cristiani.
Alle radici della crisi morale dell’Occidente. Lo studio delle cause del declino. Ci guida Il “Dopo la gloria” di Carlo Ossola.
Cominciando dal danno emergente:
La “Placuit Deo”, Lettera della Congregazione per la Dottrina della fede del 22 febbraio 2018 su “alcuni aspetti della salvezza cristiana”, richiama l’attenzione su alcune eresie risorgenti, in particolare il pelagianesimo e lo gnosticismo che affermano rispettivamente che l’uomo si salva da sé, senza la grazia e che la salvezza riguarda l’anima, non il corpo. E dal lucro cessante: il venir meno di una tradizione che garantiva un pensiero sicuro, condiviso, e la trasmissione di una vita ispirata a valori autentici.
Ricadute pastorali per la Comunità cristiana
Per quale via? E con quali pensieri? Ci viene in aiuto Papa Francesco che condivide quotidianamente il percorso faticosissimo dell’umanità offrendo alla comunità cristiana pensieri che attingono alla Parola di Dio rischiarano la strada: “Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino” ( salmo 13 )
I- Illuminante, è la Lettera apostolica: “ Aperuit Illis” del 30 settembre 2019 che può essere considerato un “vademecum”, cioè una guida, che accompagna e sorregge nella ricerca della verità attraverso le pagine della Sacra Scrittura come Gesù fece con i discepoli di Emmaus ai quali aprì il senso delle Scritture in ciò che lo riguardava. E si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero.
II - In particolare rivolge lo sguardo ai giovani con la Esortazione Apostolica “ Christus vivit”, che raccoglie il messaggio loro rivolto dai Padri Sinodali. ( 25 marzo 2019) che propone un itinerario educativo alla fede e alla vita, partendo dalla loro peculiare condizione nella società di oggi e nella chiesa. Documento da prendere in mano, insieme con I GIOVANI.
III – “Fratelli tutti”: uguaglianza, solidarietà e amicizia
La fratellanza è la nuova frontiera dell’umanità.
Lo stato di crisi che tutti notano, era già in atto da tempo, anche per i più distratti. Con una ricaduta di carattere sociale ed ecclesiale.
Conversione pastorale – una concezione illuministica della pastorale che affida la sua efficacia ai metodi e alle iniziative. Non regge più.
Capisaldi per la ripresa
Percorsi e modalità: Dio al centro
Non credere in Dio è oggettivamente pericoloso anche dal punto di vista umano. Una vita senza Dio e una società senza Dio, come possono reggere senza trasformarsi contro l’uomo? L’età secolare non cancella e non ha cancellato Dio. Al contrario si aprono grandi spazi per la fede e la spiritualità. E il pensiero testimoniato anche dalla pubblicazione “Dio, la scienza, le prove. L’alba di una rivoluzione”. Di Yves Bolloré e Olivier Bonnassies. Edizioni Sonda Milano
I maestri del sospetto: Marx, Freud, Nietzsche hanno lasciato una traccia profonda nel pensiero europeo e nella mentalità comune.. Pur tuttavia, per contrasto e a maggior ragione riaffiora insopprimibile, oggi, “La grande domanda”: perché non si può fare a meno di parlare di scienza , di fede e di Dio” ( Alister McGrasth. ( Ed. Bollati Boringhieri).
Una domanda:: in questa emergenza dove tutto è sospeso, si potrebbe proporre, – come un azzardo - una sospensione “volontaria” della incredulità? mettendola da parte. Cioé provare, per così dire, a congelarla, lasciando cadere preclusioni e pregiudizi allo scopo di riconquistare la necessaria libertà interiore difronte al mistero – che è lì intatto per tutti che sovrasta, credenti e non. Problema sempre presente. Infatti come non ricordare il celebre “etsi Deus non daretur” – anche se Dio non esistesse” – di Ugo Grosio, filosofo e teologo olandese del sec.XVII modificata da Benedetto XVI° in ”veluti si Deus daretur” vivere ”come se Dio ci fosse” “ (Benedetto XVI°,20 giugno 2005). Che sfida e che provocazione!
Castigo di Dio? Peregrina la domanda, ma non tanto. Alcuni infatti lo vanno ripetendo. No, é’ una prova, non un castigo. L’insistenza nel vedervi un castigo rivela la coscienza del peccato che sa di meritarlo. A prescindere che attribuire a Dio un sentimento di vendetta per il peccato è sbagliato perché contraddice la sua misericordia, D’altra parte, non c’è bisogno che Dio castighi, perché ci pensano gli uomini a castigarsi da soli.
Infatti i mali vengono dagli uomini, i più tremendi sono quelli che derivano dal malo uso della libertà che porta alla imprevidenza, alla irresponsabilità, alla contrapposizione, alle divisioni, all’odio, alle guerre. E Dio che cosa intende dirci, attraverso questa prova? Ecco la domanda!
Al contrario Dio viene in aiuto, come è già avvenuto. Ne sono prova anche ii numerosi Santuari disseminati in Italia e in altri Paesi che rivestono il valore di un documento storico che certifica l’intervento Dio o della Vergine nei momenti drammatici. Basti citare un solo esempio: che ne riassume tanti altri, disseminati in tempi e in luoghi diversi e cioè la “Basilica della Madonna della salute” a Venezia che il Doge e il Senato della Repubblica decretarono fosse costruita in onore della Vergine, dopo la peste del 1631, cessata per miracolo. I santi cui sono dedicati una infinità di paesi, di istituzioni culturali, di istituzioni benefiche che la toponomastica sacra certifica ampiamente.
*Dio, inoltre, ha suscitato nei momenti cruciali persone che sono andate in soccorso – a rischio personale – dei colpiti dalle epidemie. Ricordiamo, a solo titolo di esempio, S. Rocco, nato in Francia a Montpellier, che in viaggio verso Roma interrompe ad Acquapendente il pellegrinaggio per soccorrere gli appestati, così come fece, al ritorno, a Piacenza. S. Caterina da Siena che si dedicò alla cura dei colpiti dalla peste del 1374, nella sua città. S. Carlo Borromeo accorre in soccorso dei colpiti dalla peste del 1576 a Milano e S. Luigi Gonzaga a Roma nell’epidemia di peste del 1590/91 dove contrasse il contagio che lo portò alla morte. Il Borromeo, inoltre, scrisse anche un “Direttorio per l’assistenza agli appestati” perché servisse da guida.
Questi non lo fecero perché erano santi, in anticipo, cosa ritenuta scontata e perciò normale, ma, a cosa avvenuta, furono riconosciuti santi, anzitutto dal popolo, che ne fu beneficiario e testimone.
Il primato della vita spirituale
Anche per i non credenti. Le comuni radici della civiltà europea, comprese quelle cristiane, negate nel Preambolo del progetto (non portato a termine) della Costituzione dell’Europa, richiesta da Giovanni Paolo II e impedita dalla Massoneria. E della preghiera… i sette salmi penitenziali che nella storia hanno sempre accompagnato i tempi delle epidemie. Emblematico l’esempio del Petrarca che ne ha curato una versione, da pari suo, con una traduzione stupenda.
Anzitutto, mettere ordine nei propri pensieri! Da qui bisogna partire. Dal lavoro su di sé! E dalla propria Interiorità onde promuovere atteggiamenti virtuosi contrari ai difetti e alle criticità riscontrati. Liberare la mente e il cuore dalla cattiveria che spegne i sentimenti, anche tra persone vicine. Ha già fatto troppi danni! Non dimenticando che gli errori compiuti possono ripetersi. Il “Reditus peccatorum”- il ritorno dei peccati – è una tesi teologica viva nella chiesa dal X secolo. In avanti. ( cfr. Sac. Prof. Francesco Carpino “Il Reditus Peccatorum” Nelle Collezioni Canoniche e nei teologi fino ad Ugo da S.Vittore”).
La centralità della famiglia. La famiglia è uno snodo. Da lì bisogna passare. Prendendo atto che la famiglia oggi non gode di buona salute. E’ stata oggetto di attacchi micidiali di carattere ideologico che ne hanno minato la stabilità, con gravi ripercussioni di carattere sociale e politico, per cui oggi è difficile definirla, in modo univoco. La scelta del vocabolo “congiunti” - adottato dal recente decreto governativo, per la cosiddetta “fase 2” per l’emergenza coronavirus - mostra il tentativo – non riuscito - di comprendere sotto il termine adottato, relazioni e rapporti molto diversi. Inediti. Nessuno può negare che la famiglia da sicuro luogo di rifugio e di calore sia diventata in molti casi arena di litigiosità, divisioni, separazioni, contrasti ed egoismi fino a sfociare nella violenza e nella tragedia.
Si tratta di ricostruire il tessuto dei rapporti umani. Accorgendoci anzitutto di chi ci sta accanto, con simpatia, l’affetto dovuto e il rispetto che spesso è venuto a mancare. Dedicando del tempo, guardandosi negli occhi per la gioia dello star insieme. Conversando. L’uso del tempo che abbiamo a disposizione. Evitando di sprecarlo in cose cattive o vuote: cosa abbastanza facile, oggi, complice, per così dire, la tv, che può trasformarsi, se si esagera nell’uso, in una “ladra” di tempo. Tanto più i network e in particolare internet! Che sono ottimi servitori, ma possono trasformarsi in pessimi padroni! Invocando come suggerisce il salmo: “Signore, distogli i miei occhi dalle cose vane” (Salmo 118). Combattere la fretta abituale che produce ansia a chilogrammi e divora le giornate, aprendole invece alla calma e al silenzio che permette di riflettere e di rivisitare la propria vita, facendone il bilancio, dove segnare anche gli sbagli e gli autogol. Non come avvenne al chirurgo frettoloso che tagliò la gamba sana ad una sua paziente.
I mass-media. Lo spazio sempre più ampio occupato dai mass-media è da considerarsi come un prolungamento della vita non conosciuto prima, grazie alle nuove tecnologie che si sviluppano sempre di più offrendo possibilità inedite. Sono strumenti utilissimi dei quali non potremmo fare a meno tanto fanno parte delle nostre abitudini quotidiane, da essere presenze e voci familiari per quel che ci danno ogni giorno: notizie, informazioni da tutto il mondo, programmi utili, di attualità, di storia, di arte, di scienza, di economia, di politica, di ecologia. Di avvenimenti religiosi. Ma anche di evasione, che pure é necessaria. Scegliere nel ventaglio dei programmi a disposizione, evitando. la “spazzatura”, che abbonda! violenza e pornografia, orrende ambedue! Spesso intrecciate. Che abituano a considerare i comportamenti immorali come un fatto naturale., facendo perdere la distinzione tra bene e male, che sta all’origine dello sbandamento di molti. Le conseguenze stanno sotto gli occhi di tutti: violenze, delitti, femminicidi, trasgressività gravi, pericolose, oltre i limiti, nell’uso dell’alcool e della droga. Sono proposti, senza battere ciglio, modelli “strani” di umanità, da vergognarsi!
Amore alla cultura
Leggere libri utili. La cultura ha guadagnato soprattutto con quei libri con i quali gli editori hanno perso. E così per i programmi televisivi. Mettere ordine anzitutto nei propri pensieri! Partire dal lavoro su di sé! E dalla propria Interiorità. Liberare la mente e il cuore dalla cattiveria che spegne i sentimenti, anche tra persone vicine. Ha già fatto troppi danni! nella vita delle famiglie.
Il compito primario: educare!
A - Niente senza educazione! - Quanto sopra esposto a riguardo della comunità cristiana e della sua risposta all’emergenza e di riflesso l’organismo pastorale della Caritas, ai diversi livelli, che qui si inserisce a pieno titolo. Essa, infatti, è chiamata a svolgere “una funzione prevalentemente pedagogica” (art. 1 dello Statuto) anzitutto nella comunità cristiana, a partire dai problemi che deve affrontare.
In questa luce il suo compito, già nelle parrocchie, diventa molteplice: fare animazione offrendo un’informazione tempestiva e il più possibile completa; curare la formazione ecclesiale alla protezione civile, come strada concreta di risposta. La protezione civile è uno dei canali utili all’azione concreta della Caritas. Può sembrare strano, a prima vista, che debba occuparsi di un tema e di un impegno così “laico” e così tecnico. Ma la carità concreta passa per queste strade. Infatti, in simili circostanze, o si entra in questi percorsi o la solidarietà che si vuol esprimere non riuscirà a raggiungere i destinatari e può rischiare di isolarsi e diminuire di molto la propria efficacia; armonizzare l’apporto della comunità cristiana con il piano generale degli “aiuti” che è compito primario della società civile e dello Stato. La comunità cristiana è invitata a rispettare criteri e priorità stabiliti dalle autorità competenti, purché non lesivi dei valori morali e dei diritti umani. Eventualmente si tratterà di integrarne le possibili lacune, di stimolare interventi particolari per le categorie di persone in maggiore difficoltà e di denunciare, all’occorrenza, eventuali situazioni di ingiustizia, o di discriminazione nella distribuzione degli aiuti (clientelismi) o di sfruttamento, sotto varie forme.
Intervento immediato dopo l’esplosione dell’emergenza
L’ intervento immediato subito dopo l'esplosione della calamità deve avere alcuni requisiti: la tempestività che consente di intervenire nel più breve tempo possibile onde "abbreviare" le sofferenze di singoli e di comunità e soprattutto di salvare il più alto numero di vite umane; l’efficienza che garantisca un effettivo aiuto alle popolazioni colpite, evitando sovrapposizioni e confusioni organizzative. L’efficacia dell’intervento non va misurato solo nelle sue dimensioni esteriori (successo tecnico), quanto invece sul numero delle persone effettivamente raggiunte; l’imparzialità, evitando che ci sia chi riceve troppo e chi troppo poco o nulla; il rispetto della sofferenza altrui, contro ogni strumentalizzazione, per vantaggi personali o della propria parte politica.
E’ necessaria la preparazione: le azioni rapide ed efficaci non si improvvisano: sono possibili solo se si è adeguatamente preparati. Ciò significa in concreto:attuare una preparazione remota, dotandosi di strumenti adatti, di competenze nuove, di strumenti nuovi e di nuove collaborazioni; tenersi pronti ad intervenire in modo che le calamità, non ci sorprendano; la partecipazione iniziale, di solito, molto vasta e sentita, dovuta anche all’emotività, deve passare dal dono delle “cose” (aiuti) ad una vera partecipazione personale alle sofferenze altrui; è necessario, perciò, che l’azione di soccorso sia accompagnata, passo passo, da una attività di animazione, di educazione e di coordinamento, onde creare corresponsabilità e sinergia tra i vari operatori.
In missione
L’emergenza è un’opportunità che la comunità cristiana deve saper cogliere, evitando di aspettare, per il proprio impegno, occasioni che non verranno mai. Se per “missione” si intende “il coraggio di amare senza riserve immergendosi particolarmente nelle calamità e nelle urgenze del Paese”, il tempo dell’emergenza diventa per la comunità un tempo di“missione”! Infatti “mettere a disposizione le proprie energie e i propri mezzi non può essere solo il frutto di uno slancio emotivo e provvisorio. Deve essere la conseguenza logica della crescita nella comprensione della carità”. L’emergenza vissuta così, si può trasformare per la comunità cristiana in un tempo straordinario di grazia. Come Cristo, nella malattia del cieco nato, essa vi può ravvisare un’occasione perché “si manifestino le opere di Dio” (Gv 9, 3).