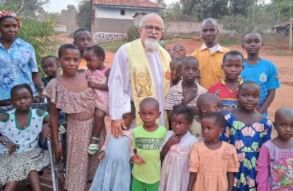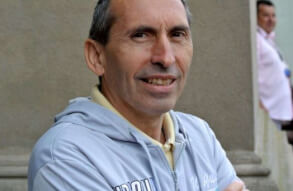Gli “hikikomori” italiani: adolescenti chiusi in una stanza in fuga dal mondo
Sono dai 30 ai 50mila i giovani "hikikomori” italiani: iniziano già dalla preadolescenza a chiudersi in casa, spesso davanti al computer, rifiutando la scuola e le relazioni. Non si sentono all'altezza degli standard sociali, sono senza opportunità lavorative e sfuggono al bullismo. Una ricerca dell'Istituto Minotauro

Gli “hikikomori” italiani. “In Italia per fortuna abbiamo forme più blande rispetto al Giappone – spiega Leopoldo Grosso, psicologo e psicoterapeuta, presidente onorario dell’associazione Gruppo Abele -: sono connesse sia ad una fobia scolare, dovuta all’angoscia di relazione rispetto ai compagni, sia a fenomeni strutturali, come la mancanza di opportunità di lavoro. L’Italia è inoltre fanalino di coda in Europa rispetto al tempo in cui i figli rimangono in casa”. I fattori psicologici sono dovuti principalmente, secondo Grosso, al “prevalere di una cultura narcisistica che ha alimentato la vulnerabilità individuale dei maschi rispetto alla definizione di sé e alla capacità di affrontare la competizione”. Ovunque, a livello scolastico, lavorativo, nei rapporti di amicizia, i ragazzi percepiscono un’ansia da prestazione che li fa sentire inadeguati. “Piuttosto di una brutta figura, preferiscono il ritiro”.
Tutto inizia nella pre-adolescenza, quando i ragazzi, spesso iper-protetti, lasciano i caldi nidi familiari e cominciano ad incontrare le prime difficoltà nel mondo dei pari. “Il debutto può essere fallimentare – spiega lo psicoterapeuta -: il proprio aspetto, modo di essere o comportamento, è oggetto di denigrazione, con quella crudeltà tipica che sanno usare i coetanei. Ogni piccolo o grande stigma viene ingigantito dallo sguardo dei compagni, che diventa giudicante”. Il bullismo diventa spesso l’episodio scatenante, i ragazzi non vogliono più andare a scuola. Quello però è solo il pretesto: “il testo si tesse molto prima ed è dovuto alla fragilità nel rapporto con gli altri, ai timori, alle timidezze”. Chiudersi in camera o in casa è una scelta difensiva: piuttosto che sentirsi denigrati ci si ritira e si compensa con internet, che permette di costruire altri mondi. “Il virtuale accusato di creare dipendenza – osserva l’esperto -, in queste situazioni invece aiuta molto. E’ l’unico modo per entrare in contatto con altri ragazzi, ad esempio attraverso i giochi di ruolo”.
Le strategie d’accompagnamento e di prevenzione. In Giappone, dove l’isolamento può durare in media anche sei anni, ci sono già tanti centri di recupero: prima si incontrano i genitori, poi si cerca un approccio con il ragazzo. Se non si riesce si utilizzano “finte sorelle o fratelli maggiori” che stazionano in casa e cercano di agganciare il ragazzo su qualche interesse comune. In Italia, ammette Grosso, “sono sempre di più i genitori che vengono a chiedere aiuto”. La strategia è quella “di aiutarli a capire gli atteggiamenti del figlio e non lottare contro il computer, altrimenti l’aggressività viene spostata verso di loro”. Al contrario è importante cercare di mantenere in casa, per quanto possibile, una comunicazione, per facilitare l’ingresso di un giovane terapeuta o la ripresa di qualche attività a scuola e nel mondo. Strategie che richiedono però “un buon investimento di energie e almeno tre persone che si occupino dei genitori e del figlio; risorse che oggi i servizi pubblici non sono in grado di sorreggere”. La prevenzione invece si fa invitando i ragazzi a coltivare interessi e passioni, educandoli ad usare strumenti critici per non fondare la propria identità su modelli troppi alti e distanti. “Altrimenti diventano inevitabilmente perdenti”.

PATRIZIA CAIFFA
21 gen 2016 00:00