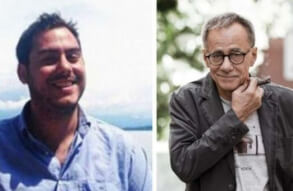La ricerca di felicità effimera

Che l’essere umano ricerchi la felicità è storia nota. In questa ricerca della felicità, l’umanità ha cercato scorciatoie e aiuti esterni che non solo non hanno raggiunto l’obiettivo ma hanno trasformato l’esistenza in dolore e sofferenza: esattamente il contrario di quello che si voleva perseguire. Il dolore vissuto direttamente così come quello causato agli altri marchia in modo indelebile i vissuti e segna in profondità le relazioni umane: è questa la narrazione nelle storie di redenzione e di recupero di chi è riuscito a dare una svolta alla propria vita. Cambiano tempi, sostanze, consumi, bisogni, risposte, ma sempre scatta quel meccanismo di immediata ricerca di felicità o di rifugio davanti a un mondo sempre più complesso. La ricerca non avviene in sé ma in cose: in droghe, farmaci, alcool, gioco d’azzardo, internet, social, video games, shopping compulsivo, sesso… Sembra, per alcuni aspetti, una lotta impari: ogni volta che si sperimenta un antidoto ecco che si scopre una nuova variante, una mutazione che socialmente e clinicamente deve essere affrontata con percorsi di prevenzione e recupero che arrivano sempre dopo aver già coinvolto una fascia di popolazione in età sempre più precoce e giovane. Anche i recenti ed efferati fatti di cronaca dimostrano che dalla fanciullezza biologica si passa a un’adultità comportamentale che brucia tappe fondamentali della crescita e dello sviluppo graduale ed armonico delle relazioni affettive e sociali. Tanti bambini si ritrovano già adulti saltando la preadolescenza e l’adolescenza, non solo nelle zone di estrema povertà o di guerra, ma anche in realtà della nostra Italia dove c’è una povertà educativa per assenza di modelli adulti positivi e stimolanti.
Non voglio qui entrare in merito ai meccanismi che a livello organico attivano quegli agiti compulsivi che portano a una dipendenza, ma certo è che chiunque abbia a cuore il futuro delle nostre comunità civili e parrocchiali deve interrogarsi e intervenire. Quando il fenomeno delle sostanze stupefacenti esplose in modo drammatico anche nella nostra provincia nei primi anni Settanta del secolo scorso, la prima risposta organizzata venne da alcuni preti coraggiosi che animarono le proprie comunità attivando risposte concrete e organizzate per farvi fronte. Come dimenticare don Redento, don Serafino, don Piero e con loro tanti laici impegnati nelle parrocchie e negli oratori della provincia. Senza le loro intuizioni e il loro impegno, non si sarebbe potuto arginare una problematica così impattante che ha segnato per decenni tutti i nostri luoghi di crescita: la famiglia, la scuola, il mondo del lavoro, i contesti sportivi e ricreativi, gli oratori. Paradossalmente oggi abbiamo più risorse e conoscenze su questi temi, siamo anche più strutturati come servizi pubblici e privati, tuttavia riusciamo sempre con maggior fatica a fronteggiare la molteplicità di dipendenze che affliggono la nostra società. Ancora oggi, tra l’inizio dell’utilizzo di una sostanza stupefacente e la consapevolezza della necessità di presa in carico in un servizio di cura passano mediamente a 10 anni. Allora dobbiamo porci qualche domanda: è solo un problema di cura? È solo un problema dei servizi specialistici? Non è un mio problema perché non sono coinvolto direttamente? O non è al contrario un problema che coinvolge tutti nella società. Quindi anche le nostre comunità parrocchiali che devono ritornare a farsi carico di un ruolo educativo e stimolante, parlandone apertamente e stringendo alleanze e collaborazioni con chi opera quotidianamente in questo settore.